Ultime Notizie
- Diciannove azzurri per Jumping Verona: ai 9 convocati dalla FISE si sono aggiunte 10 “wild card”
- Jumping Verona: tanti i ‘big’ attesi per la tappa di Coppa del Mondo
- FESTIVAL CINEMA DI ROMA: il 23 ottobre al Teatro Olimpico proiezione ufficiale del documentario dedicato al pilota Giacomo Agostini
- Fieracavalli 2024: Il grande Sport Nazionale e Internazionale è di scena al padiglione 8
- Fieracavalli 2024: Il Western Show, il mondo USA, è nel padiglione 12
La storia di Natale: Vlade e Drazen, da fratelli a nemici
dic 24, 2013 Claudio Pellecchia Sport USA 0
Roma. Chiunque di noi abbia mai preso in mano una palla a spicchi ha impresso a fuoco nella mente il “Dream Team”, la squadra statunitense delle Olimpiadi ’92. Vale a dire il più grande concentrato di talento nella storia dello sport contemporaneo con interpreti unici e irripetibili: Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, John Stockton, Karl Malone, Charles Barkley, Patrick Ewing, David Robinson, Clyde Drexler, Chris Mullin e Christian Laettner (che sembrava un passante capitato li per caso, ma in realtà sapeva giocare pure lui). Altri “Dream Team” hanno provato a insidiare l’aura di leggenda di questi semidei (ci è andata vicino – se per vicino si intende la distanza tra la Terra e il Sole – la squadra dei recenti Giochi di Londra) ma, nell’immaginario collettivo, i dodici di Barcellona resteranno sempre gli UNICI. E cosi, nei secoli dei secoli (Amen).
Eppure, non più tardi di qualche tempo prima il Dream Team aveva il suo ideale archetipo nel vecchio continente. E non è da escludere che, in una qualche misura, il progetto olimpico del ’92 abbia trovato la sua genesi nella voglia di misurarsi con una squadra così in cui giocavano, tra gli altri, Toni Kukoč, Dražen Petrović, Dino Radja, Žarko Paspalj e Vlade Divac. E’ la nazionale jugoslava, forgiata nel talento di giocatori che si conoscono dalle giovanili, condividendo tutto dentro e fuori dal parquet. In particolare, sono gli ultimi due che ci interessano. Divac e Petrović, da pronunciare quasi tutto d’un fiato. Due personalità così diverse, eppure così uguali. Vlade Divac, pivot longilineo, 120 chili distribuiti su 216 centimetri. Rimbalzista troneggiante e passatore sublime, movimenti in post eleganti come il volo di un airone che plana sull’acqua. E poi Dražen Petrović, soprannominato il “Mozart dei canestri”, guardia tiratrice di 1 e 96. Non servono parole, basta andarsi a rivedere i video delle sue partite. Vedrete che Dražen segue perfettamente uno spartito immaginario, che vale per lui e lui soltanto, guidato dal suo genio: ogni tiro, ogni virata, ogni passaggio, ogni appoggio al vetro sono al ritmo delle note di un basket celestiale. Uno dei più grandi di tutti i tempi, uno che in America definirebbero “hall of famer”.
Vlade e Dražen sono l’esempio di come gli opposti si attraggano, in campo e fuori: la loro intesa è tecnica ma anche caratteriale, pur essendo due personalità profondamente diverse, guascone e istrionico Vlade, tranquillo e serioso Drazen. La principale differenza è però etnica: Vlade è serbo, mentre Dražen è croato, nonostante giochino sotto bandiera jugoslava.
La nazionale dei balcani, con Dušan Ivković deus ex machina in panchina, è stata pensata con un unico obiettivo: dominare, portando in giro per il mondo una nuova idea di pallacanestro. Un gioco solo all’apparenza essenziale, dai solidi fondamentali, ma che si adattasse e desse libero sfogo al talento dei cinque moschettieri, Petrović in particolare. I risultati sono, per certi versi, scontati. Si comincia con le Olimpiadi di Seul del 1988 e con la finale per l’oro disputata contro l’Unione Sovietica di Arvydas Sabonis, giustiziere dell’ultima nazionale americana di soli collegiali. I nostri portano via “solo” l’argento, ma firmano davanti al mondo la propria dichiarazione d’intenti. Gli europei del 1989, non vinti ma stravinti, paiono una pura e semplice formalità: lo “showtime” di Magic, Worthy e Kareem sembra, di colpo, sbarcato anche alle latitudini europee. In finale, la Grecia prende coscienza del caterpillar che l’ha spianata solo al rientro negli spogliatoi. Tre quinti del quintetto ideale sono jugoslavi (Petrović, Radja, Paspalj), con Dražen votato, ovviamente, mvp.
Il 1989, però, finisce sui libri di storia non certo per una squadra di basket, per quanto forte essa sia. Il 9 novembre, il mondo cambia per sempre: cade il muro di Berlino, con tutte le conseguenze di cui sarebbe fuori luogo parlare qui. Tuttavia, questo è un avvenimento destinato a cambiare le vite di Divac e Petrović, anche se loro ancora non lo sanno; in Jugoslavia, infatti, cominciano a spirare sempre più forti gli alisei di nuove spinte indipendentiste, da parte delle nazioni che la compongono. In particolare sono i serbi e croati a non vedersi particolarmente di buon occhio.
Per Vlade e Dražen, però, non era ancora il momento di fare i conti col destino. Nei mesi precedenti quell’evento storico arriva finalmente il grande salto nella lega che, più di ogni altra, ti garantisce fama, gloria ed anche un bel po’ di dollari. Il che, soprattutto se vieni da un luogo dove il tuo primo canestro arriva su un ammasso di pietre e fango, tendi a non disprezzarlo. Divac viene scelto dai Los Angeles Lakers (e dove altro poteva andare a giocare se non a Hollywood uno così) al draft con la pick numero 26, mentre Petrović finisce ai Portland Trail Blazers che lo avevano scelto già nel 1986. L’impatto dei nostri due eroi è molto diverso, quantomeno inizialmente. Il primo si inserisce da subito nei meccanismi dei Lakers, con Magic che lo prende sotto la sua ala protettrice ; il secondo, abituato a sessantelleggiare in scioltezza nelle ultime stagioni di Eurolega, si trova, invece, a dover fare i conti con una realtà durissima, fatta di tanta panchina e pochi minuti in campo. Del resto siamo in un’epoca in cui gli stranieri, soprattutto se europei, vengono guardati con grande sospetto all’interno della lega. Se poi sei, di fatto, l’ultimo nelle rotazioni di un reparto guardie che annovera, fra gli altri, Clyde Drexler e Danny Ainge, allora le prospettive non possono che essere difficili. Nonostante tutto, i Blazers arrivano comunque alle Finals, perse malamente contro i Detroit Pistons di Isiah Thomas e dei “Bad Boys”; i Lakers, invece, devono arrendersi in semifinale di conference ai Phoenix Suns. La prima annata oltreoceano rafforza ancor di più l’amicizia e il rapporto tra Vlade e Dražen: i due si sentono praticamente ogni sera, raccontandosi le impressioni sulle partite e su di un mondo totalmente nuovo. Manco a dirlo, Petrović trova nell’amico il primo sostegno che lo aiuta a non mollare tutto per tornarsene a fare la superstar in Europa. E poi ci sono i mondiali in Argentina, da giocare insieme ai compagni di sempre, agli amici di sempre.
Già, i mondiali del 1990. Contestualmente il punto più alto e quello più basso della storia della pallacanestro jugoslava. Ma andiamo con ordine. A casa, nei balcani, la situazione è oramai definitivamente compromessa. Il nazionalismo sta alimentando il fuoco del sanguinoso conflitto etnico.
In questo scenario ben pochi hanno voglia di pensare alla nazionale di Ivković. Eppure, i giocatori sono convinti che una loro vittoria possa contribuire a tenere unito un paese che unito non voleva essere più. Il parquet fornisce il suo inequivocabile responso: i nostri passeggiano fino alla finale dove schiantano quel che resta dell’Unione Sovietica. Arrivano i festeggiamenti del dopo gara, con i giocatori che fanno numerosi giri di campo. ‹‹Ju-go-slavia, Ju-go-slavia!›› l’urlo ritmato dei nuovi padroni del mondo cestistico rivolto ai propri sostenitori. Ma arriva la scena madre, il fotogramma che cambierà per sempre il destino dei protagonisti, in particolare dei nostri protagonisti. Anni dopo, Vlade confesserà amaramente: ‹‹Ci vogliono anni per costruire un’amicizia e un solo attimo per distruggerla››.
Accade che un tifoso entri in campo, vestito sì dei colori della bandiera jugoslava ma con in più lo stemma della Croazia; Divac, che è serbo (e, quindi, esponente di un’etnia che non andava d’accordo con i croati da circa duecento anni o giù di lì), strappa la bandiera dalle mani del ragazzo e la getta via. Il suo gesto vorrebbe, nelle intenzioni, evitare di portare i venti della guerra civile all’interno di uno dei pochi momenti di gioia per il popolo slavo. Vlade non si sente e non vuole essere né serbo, né croato. Vlade è jugoslavo e vuole che tutti capiscano che, per lui, non esistono differenze etniche o di razza.
Petrovic non si accorge subito della scena, la leggerà il giorno dopo dai giornali, ed è quello il momento in cui la nostra storia cambia direzione. Vlade e Dražen hanno diviso per anni tutto delle loro vite. Ma tutto si dissolve in un nuvola di incomprensione, di fronte ad un gesto male interpretato. Petrović non parlerà più a Divac, non gli perdonerà mai di aver mancato di rispetto in quel modo al suo paese. Non accetta spiegazioni o ragioni: l’amico diventa, di colpo, uno dei tanti da combattere e disprezzare. Una delle più belle storie dello sport si trasforma in una scontata e triste vicenda di odio e incomunicabilità. Divac, negli anni a venire, inseguirà in tutti i modi quel fratello perduto, cercando disperatamente di dimostrare che lui è lo stesso uomo di prima: lui è sempre e solo Vlade, il compagno di stanza dai tempi della juniores. Cosa vuoi che conti a quale etnia appartieni. Ma l’altro da quell’orecchio non ci sente e non vuole sentirci: oppone quella fredda indifferenza peggiore perfino dell’odio che si può riservare al peggiore dei nemici.
Paradossalmente (o forse no, visto che il destino, quando ci si mette, sa essere davvero crudele), la carriera Nba di Drazen, da quel momento, ha una svolta in positivo. Passato, nel 1991 dai Trail Blazers ai New Jersey Nets, il “Mozart dei canestri” ritrova di colpo il filo rosso di quel talento che in America sembrava perduto. Forte di un minutaggio maggiore, ritorna a giocare da Dražen. I numeri sono impressionanti: 20.6 punti di media a partita (che diventeranno 23 nella stagione successiva) e 51% complessivo dal campo, con i Nets capaci di due qualificazioni consecutive ai playoff. Resta memorabile una partita contro gli Houston Rockets, con Vernon Maxwell capace di dichiarare nel pre gara: ‹‹Deve ancora nascere un europeo bianco che mi faccia il culo››, ricevendo, in risposta, 44 punti stampati in faccia uno dopo l’altro, tiro dopo tiro. E poi l’affetto dei compagni e della gente, la felicità ritrovata nel calcare i parquet più prestigiosi del mondo da assoluto protagonista, l’oramai riconosciuto status symbol di “superstar”. In più c’è anche la nuova nazionale croata, condotta all’argento alle Olimpiadi del 1992, nella finale contro quel Dream Team di cui si è già detto all’inizio. Ma sempre con la “macchia” del rapporto compromesso con Divac, perfettamente fotografato in un’emblematica scena in un fine gara tra Lakers e Nets: Vlade si avvicina, cerca di dire qualcosa, ma l’altro si gira per un momento, borbotta qualcosa e rientra senza battere ciglio negli spogliatoi. L’immagine degli oltri 2 metri di Divac immobili sul parquet dopo quanto descritto fa quasi tenerezza: un uomo enorme, inarrestabile anche per alcuni tra gli atleti più forti del mondo, spazzato via dall’incommensurabile freddezza di un singolo gesto.
Siamo a giugno del 1993, giorno 7, a stagione Nba dei Nets conclusa da un pezzo. Drazen ha disputato il giorno prima in Polonia l’ennesima partita di qualificazione europea contro la Slovenia, mettendo a referto il solito trentello di prammatica. Diversamente dagli altri compagni, però, decide di rientrare a casa in auto, accompagnato dalla fidanzata Klara, con il resto della squadra in aereo. Dino Radja ricorda: ‹‹A un certo punto stavamo volando sopra delle nuvole nere cariche di pioggia. Il comandante ci disse che eravamo sopra Monaco e, per un attimo, mi ritrovai a pensare che, magari, Dražen era proprio sotto di noi››. Non può immaginare che in quel momento Dražen non c’è già più, portato via proprio dall’acqua di quelle nuvole maligne. La sua macchina, guidata dalla compagna mentre lui riposava sul sedile del passeggero, si è schiantata all’altezza di Denkendorf contro un camion a causa dell’asfalto viscido e infido quasi quanto la sorte stessa. Petrović muore sul colpo, nel sonno, senza nemmeno accorgersi a cosa stava andando incontro. Ai compagni di squadra e ad un’intera nazione non resta che piangere un simbolo ma, soprattutto, l’uomo e l’amico di sempre. Ancora oggi, in Croazia, il 7 giugno è giornata di lutto nazionale.
Dall’altra parte del mondo, intanto, Vlade è in vacanza con la famiglia. Si trova in piscina, ma ha come un presentimento e rientra prima nella camera del suo albergo, accendendo la televisione. I principali network hanno già dato la notizia; l’iniziale incredulità lascia il posto al pianto disperato di un uomo che ha perso suo fratello. Per sempre. Gli verrà persino impedito di partecipare ai funerali, per ragioni politiche e di sicurezza. Perché la cieca idiozia dell’odio non ha rispetto nemmeno della morte. Divac riuscirà a tornare in Croazia solo molti anni dopo, accompagnato dalla troupe di ESPN intenta a girare il documentario “Once Brothers”, per visitare per la prima volta, la tomba dell’amico parzialmente imbiancata dalla neve e lasciare una foto di loro due insieme poggiata delicatamente accanto a un mazzo di fiori. Qualche istante di preghiera, quanto basta per rivivere gioie e dolori di una vita precedente, passata fianco a fianco, uniti come solo due fratelli potevano essere.
Forse, Vlade e Dražen sono finalmente riusciti a fare la pace. Buone feste a tutti.
Claudio Pellecchia
Nasce a Napoli il 07/09/1987. Già collaboratore/redattore per il "Roma", "Il Mattino" e toniiavarone.it, nonostante la laurea in Giurisprudenza ha deciso comunque di intraprendere l'avventura rischiosa e affascinante del giornalismo. Pubblicista dal 2013, ama lo sport e le storie che vi ruotano attorno. Occuparsi di Nba non è un lavoro, ma un piacere.
Articoli Correlati
-
 Diciannove azzurri per Jumping Verona:...
Diciannove azzurri per Jumping Verona:...ott 25, 2024 0
-
 Jumping Verona: tanti i ‘big’...
Jumping Verona: tanti i ‘big’...ott 24, 2024 0
-
 FESTIVAL CINEMA DI ROMA: il 23 ottobre...
FESTIVAL CINEMA DI ROMA: il 23 ottobre...ott 15, 2024 0
-
 Fieracavalli 2024: Il grande Sport...
Fieracavalli 2024: Il grande Sport...ott 14, 2024 0
Altre Notizie
-
 Carlos Coronel, Noah Eile e Lewis...
Carlos Coronel, Noah Eile e Lewis...ott 08, 2024 0
-
 Crew stun Red Bulls in stoppage time,...
Crew stun Red Bulls in stoppage time,...ott 01, 2022 0
-
 Gonzalo Higuain delivers late heroics...
Gonzalo Higuain delivers late heroics...set 30, 2022 0
-
 Union scorers come through in 2-0 win...
Union scorers come through in 2-0 win...set 03, 2022 0
Seguici su Facebook
PATRIMONIO ITALIANO AWARD
PATRIMONIO ITALIANO TV
-

-

-
 LET’S SING @ RADIO ITALIA: Il Karaoke per Nintendo Wii
LET’S SING @ RADIO ITALIA: Il Karaoke per Nintendo Wiiott 01, 2013 6
-
 Ecco i Microfoni wireless di SingStar per Playstation
Ecco i Microfoni wireless di SingStar per Playstationmag 22, 2009 5
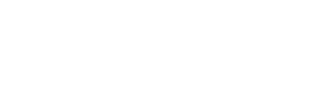



11 years ago
11 years ago
11 years ago
11 years ago