Ultime Notizie
- Diciannove azzurri per Jumping Verona: ai 9 convocati dalla FISE si sono aggiunte 10 “wild card”
- Jumping Verona: tanti i ‘big’ attesi per la tappa di Coppa del Mondo
- FESTIVAL CINEMA DI ROMA: il 23 ottobre al Teatro Olimpico proiezione ufficiale del documentario dedicato al pilota Giacomo Agostini
- Fieracavalli 2024: Il grande Sport Nazionale e Internazionale è di scena al padiglione 8
- Fieracavalli 2024: Il Western Show, il mondo USA, è nel padiglione 12
“My Way”: omaggio ad Allen Iverson.
mar 01, 2014 Claudio Pellecchia Sport USA 0
Roma. Nell’abbondante quarto di secolo passato su questo “blocco minerale orbitante intorno al sole” (tante grazie, avvocato) sono state relativamente poche le occasioni in cui, come un replicante di “Blade Runner” di ritorno dai bastioni di Orione, ho potuto vedere cose “che voi umani non potreste immaginarvi”: una, abbastanza recente, quando, gettando l’occhio sulla classifica della Eastern Conference 2013/2014, ho potuto constatare come i Bobcats siano in zona playoff (aspettate che lo riscrivo: I BOBCATS SONO IN ZONA PLAYOFF); l’altra, abbastanza datata, nell’unica occasione in cui Michael Jeffrey Jordan è stato messo, letteralmente, col culo per terra (scusate il francesismo, ma credo renda meglio l’idea). E no, non sto parlando di un omonimo: proprio QUEL Michael Jeffrey Jordan. Non ci credete? Permettetemi di rinfrescarvi la memoria:
Questo è il primo fotogramma di uno dei canestri più belli che siano mai stati realizzati. Un “anckle breaking” al più grande di sempre, concluso con un tiro che a malapena scuote la retina, per quanto è rapido,regale, perfetto il movimento che lo accompagna. L’autore è un imberbe rookie (1 e 83 per 77kg) da Georgetown University, prima scelta assoluta al Draft 1996, che, al suo primo anno in Nba, ha deciso di ‹‹mostrare al mondo il talento che Dio gli aveva donato, con il cielo come unico limite››.
 Doveroso flashback. Allen Ezail Iverson nasce il 7 giugno 1975 a Hampton, Virgina. Appena è in grado di reggersi in piedi dimostra una particolare attitudine allo sport, unita ad una feroce voglia di primeggiare sempre, comunque contro chiunque. Nel suo terzo anno alla Bethel High School, vince non solo il campionato statale di basket (e fin qui), ma anche quello di football, risultando per distacco il miglior quarterback dello Stato. Si intuisce subito che abbia qualcosa di speciale: basta guardarlo negli occhi per comprendere la portata del sacro fuoco che lo anima. Un fuoco alimentato dalla voglia di primeggiare, di tirarsi fuori dal limbo di una vita che, fin dall’inizio, gli fa conoscere la povertà, quella vera, fatta di stenti e privazioni. Lo sport diviene per il giovane Allen la principale via di fuga dalla strada, sebbene abbia conosciuto già da adolescente le patrie galere a causa di una rissa in un bowling. Ecco, un’altra costante che lo accompagnerà per tutta la sua vita: trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Salterà l’ultimo anno di liceo e non giocherà mai più a football, con la fama di “bad boy” che gli chiude le porte di molti college. Tocca a mamma Ann andare a supplicare il leggendario coach di Georgetown John Thompson, che, alla fine, si lascia convincere. Verrà ripagato da due anni giocati a livelli spaziali, con l’ovvia elezione nel quintetto ideale degli “All American”, il primo posto nella classifica delle rubate e la costante presenza tra i primi cinque marcatori. All’inizio del 1996/1997 decide di dichiararsi eleggibile per il draft, come prima scelta assoluta. Sono i Philadelphia 76ers ad aggiudicarsi la “lotteria Iverson”, quella che passa una volta nella vita. Forse mai. La stagione è una delle più spettacolari mai disputate da una matricola, con la chicca dell’abbattimento di un record storico: con 4 partite consecutive a oltre 40 punti di media (riscrivo anche qui: 4 PARTITE CONSECUTIVE OLTRE 40 PUNTI DI MEDIA DA MATRICOLA) sposta il limite fissato da Wilt Chamberlain nella stagione 1959/60. Niente sembra poterlo fermare. Neppure quella che è unanimemente considerata la personificazione del gioco ideato dal professor Naysmith (sempre sia lodato) in quel di Springfield.
Doveroso flashback. Allen Ezail Iverson nasce il 7 giugno 1975 a Hampton, Virgina. Appena è in grado di reggersi in piedi dimostra una particolare attitudine allo sport, unita ad una feroce voglia di primeggiare sempre, comunque contro chiunque. Nel suo terzo anno alla Bethel High School, vince non solo il campionato statale di basket (e fin qui), ma anche quello di football, risultando per distacco il miglior quarterback dello Stato. Si intuisce subito che abbia qualcosa di speciale: basta guardarlo negli occhi per comprendere la portata del sacro fuoco che lo anima. Un fuoco alimentato dalla voglia di primeggiare, di tirarsi fuori dal limbo di una vita che, fin dall’inizio, gli fa conoscere la povertà, quella vera, fatta di stenti e privazioni. Lo sport diviene per il giovane Allen la principale via di fuga dalla strada, sebbene abbia conosciuto già da adolescente le patrie galere a causa di una rissa in un bowling. Ecco, un’altra costante che lo accompagnerà per tutta la sua vita: trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Salterà l’ultimo anno di liceo e non giocherà mai più a football, con la fama di “bad boy” che gli chiude le porte di molti college. Tocca a mamma Ann andare a supplicare il leggendario coach di Georgetown John Thompson, che, alla fine, si lascia convincere. Verrà ripagato da due anni giocati a livelli spaziali, con l’ovvia elezione nel quintetto ideale degli “All American”, il primo posto nella classifica delle rubate e la costante presenza tra i primi cinque marcatori. All’inizio del 1996/1997 decide di dichiararsi eleggibile per il draft, come prima scelta assoluta. Sono i Philadelphia 76ers ad aggiudicarsi la “lotteria Iverson”, quella che passa una volta nella vita. Forse mai. La stagione è una delle più spettacolari mai disputate da una matricola, con la chicca dell’abbattimento di un record storico: con 4 partite consecutive a oltre 40 punti di media (riscrivo anche qui: 4 PARTITE CONSECUTIVE OLTRE 40 PUNTI DI MEDIA DA MATRICOLA) sposta il limite fissato da Wilt Chamberlain nella stagione 1959/60. Niente sembra poterlo fermare. Neppure quella che è unanimemente considerata la personificazione del gioco ideato dal professor Naysmith (sempre sia lodato) in quel di Springfield.
E questo ci riporta, con la velocità di un “flash forward” al fotogramma di cui sopra, alla sfida . “Il momento è catartico” direbbe Flavio Oreglio. Allen riceve palla in punta e Phil Jackson, dalla panchina dei Bulls, chiama quello che, più che un cambio difensivo è una sfida: ‹‹Michael!››. Forza ragazzino, vediamo che sai fare. “The Answer” (c’è poco da fare se ti danno il soprannome giusto sei a posto per sempre) mette in scena la più bella versione del “u-tep, too step” che si sia mai vista. Con mille scuse al suo inventore Tim Hardaway. Per MJ far combaciare le regali terga col parquet (visto? Stavolta ho edulcorato) è un attimo, col tiro che è partito in una frazione di secondo: “ciuff” e pubblico dell’allora Core States Center completamente impazzito. “Everyone wants to be like Mike”: tutti, meno uno. Lui. Non si era mai visto, prima di allora, un bipede così veloce su un campo da basket. Da playmaker, spetterebbe a lui condurre il contropiede: il condizionale, come si dice in questi casi, è d’obbligo. Perché, il lungo ha a malapena il tempo di effettuare l’outlet pass dopo il rimbalzo, che il numero 3 è già volato a canestro. Nemmeno i compagni riescono a stargli dietro. Già, i compagni: seconda costante della sua carriera. Non avrà mai, sostanzialmente, un “supporting cast” alla sua altezza, in grado di fargli vincere la guerra e non solo la singola battaglia. E l’eccessiva dose di individualismo che mette in mostra sul parquet non lo aiuta di certo. Già al termine della prima stagione, culminata col “rookie of the year” ma con un record di squadra perdente (22-60), la fama di egoista aderisce perfettamente al metro e ottantatre della superstar dei Sixers. ‹‹Io, me stesso e Iverson›› dirà Charles Barkley, fotografando il pensiero di appassionati e addetti ai lavori.
Non si era mai visto, prima di allora, un bipede così veloce su un campo da basket. Da playmaker, spetterebbe a lui condurre il contropiede: il condizionale, come si dice in questi casi, è d’obbligo. Perché, il lungo ha a malapena il tempo di effettuare l’outlet pass dopo il rimbalzo, che il numero 3 è già volato a canestro. Nemmeno i compagni riescono a stargli dietro. Già, i compagni: seconda costante della sua carriera. Non avrà mai, sostanzialmente, un “supporting cast” alla sua altezza, in grado di fargli vincere la guerra e non solo la singola battaglia. E l’eccessiva dose di individualismo che mette in mostra sul parquet non lo aiuta di certo. Già al termine della prima stagione, culminata col “rookie of the year” ma con un record di squadra perdente (22-60), la fama di egoista aderisce perfettamente al metro e ottantatre della superstar dei Sixers. ‹‹Io, me stesso e Iverson›› dirà Charles Barkley, fotografando il pensiero di appassionati e addetti ai lavori.
L’estate del 1997 porta, però, una svolta: a Philadelphia arriva Larry Brown, allenatore con la A maiuscola. Lo scontro appare inevitabile, per non dire sicuro: da una parte un ebreo newyorkese con la fama di “aggiusta squadre”, dall’altra la giovane stella che viene dal ghetto che agisce di testa sua. Tradizione e innovazione, logica e istinto, schemi sulla lavagnetta e “me ne frego, tanto posso battere tutti dal palleggio”: non può durare, non dovrebbe durare. Eppure, persino Brown è intrigato dal giocatore che si ritrova ad allenare: ‹‹In campo lotta. E so che vuole solo vincere. Non sempre ci prova nel modo giusto, ma non ci sono dubbi che sia un lottatore nato››. E allora, ecco l’intuizione che ti cambia la carriera: Iverson, tra lo stupore generale, viene spostato in guardia. Il roster viene completamente stravolto e ricostruito intorno al piccolo grande leader, che viene circondato di giocatori altruisti e gregari. L’investimento paga grandi dividendi: 31 vittorie nel ’98, una stagione vincente l’anno successivo, con Allen che riporta i Sixers ai playoff da capocannoniere. Dopo aver fatto fuori i Magic (con Iverson che, nella partita del 13 maggio, stabilisce il record di palle rubate – 10 – in una gara di post season), la corsa si ferma contro Indiana al secondo turno. Nel 2000, per la prima volta, è All Star Game. Poi, ancora playoff e ancora eliminazione ad opera dei Pacers. Che non sono, però, il principale problema. Vestiti, capigliatura, tatuaggi, modo di parlare, sono un continuo costruirsi di una certa immagine, le cui proiezioni che arrivano al pubblico non sono necessariamente positive. Anzi, alle volte sembra che lo faccia apposta. Una sfida continua contro il mondo intero, anche a quelli che ti sono più vicino: ‹‹I don’t wanna be Michael Jordan, I don’t wanna be Magic, I don’t wanna be Bird or Isaiah. I don’t wanna be any of those guys. You know when my career is over, I wanna look in the mirror and say: ‘I did it my way!’››. Ora, in un’ideale classifica delle cose da non dire a un allenatore come Brown, le parole “My Way” (a meno che tu non sia Frank Sinatra: anzi, forse nemmeno in quel caso) sarebbero certamente in cima. Nell’estate del 2000, il muro faticosamente eretto per celare i dissidi quotidiani tra le due coscienze della Philadelphia cestistica, cade. E l’effetto è deflagrante, con Iverson che non finisce ai Detroit Pistons solo perché Matt Geiger rifiuta di cedere il 15% dei proventi che gli sarebbero spettati in caso di una sua cessione. Si tratta della svolta numero due. ‹‹Ho sempre voluto essere un Sixer. Mio padre tifava Sixers e io ho sempre voluto essere la prima scelta e non lasciare mai Phila. Ho voluto iniziare qui la mia carriera e voglio finirla nella stesso posto. Voglio restare dove sono, dove la gente mi ama e dove io amo loro››. La più classica delle folgorazioni sulla via di Damasco.
Sulle note di “Ricominciamo” Brown e Iverson decidono di riprovarci. E la stagione 2000/2001 diventa una delle più memorabili mai disputate da un singolo giocatore. Non solo e non tanto per l’ovvio Mvp, che risulta addirittura doveroso quando ci si trova di fronte ad un giocatore del genere: ma perché, forse per la prima e unica volta, Allen crede che far parte di una squadra sia il sistema per poter vincere. Si gioca alla sua maniera e a quella di Brown. Ed è chiaro come nessuna forza competente possa frapporsi sulla strada del successo. All’All Star Game di Washington, il patto d’acciaio viene sigillato: ‹‹Where’s my coach? My coach. Coach Brown!››. Come Rocky che chiama Adriana, volendo restare in ambito philadelphiano. Il premio per essere stato il migliore nella partita delle stelle non è più un riconoscimento personale: diventa un tributo all’allenatore che ti ha cambiato la carriera. Il miglior record a Est è solo il punto di partenza di un viaggio che passa da Indiana (finalmente rispedita a casa), dalla memorabile battaglia contro Toronto (in una sfida all’ultimo cinquantello con Vince Carter) vinta in 7 gare, dal 4-3 rifilato ai Bucks di Ray Allen in finale di Conference. D’improvviso gente come Matt Geiger, Dikembe Mutombo, Tyrone Hill, George Lynch, Eric Snow e altri 6 presi a caso si ritrovano trascinati alle Finals contro i Los Angeles Lakers della prima ondata (quella, per intenderci, di Kobe e uno Shaq che aveva ancora voglia di allenarsi). Nessuno dà loro una possibilità. E con buone ragioni, visto che i purple and gold arrivano all’appuntamento di giugno senza aver perso una sola partita durante tutti i playoff e con il vantaggio del fattore campo.
Può Davide battere Golia? Gara 1 di finale allo Staples Center è un qualcosa che, a distanza di anni, faccio ancora fatica a spiegare. Quarantotto minuti di battaglia, con questo cardellino che non ha paura di andare in penetrazione contro lo Shaquille O’Neal più dominante di sempre. Si va al supplementare, 76ers a -5 negli ultimi due minuti. Sarebbe già un successo. Poi, accade questo:


‹‹He steps on Lue!››. Giuro che prima o poi la userò come suoneria del cellulare. 7 punti in fila, 48 totali (riscrivo per l’ultima volta: QUARANTOTTO PUNTI ALLO STAPLES CENTER CONTRO I LAKERS ALLE FINALI NBA). Vittoria 101-107. E show in conferenza stampa: ‹‹Dunque, un sacco di gente ha scommesso che ne perdevamo quattro di fila. Immagino che sia rimasta in bolletta. Spero che nessuno abbia scommesso la vita sulla nostra sconfitta, perché oggi sarebbe morto››.
Riformuliamo la domanda biblica: può Davide battere Golia? Si, ma alla lunga Golia vince. I Lakers si prendono il secondo pezzo del “three peat” in cinque gare. Ma Iverson si prende finalmente l’immensa dose di rispetto che si merita un uomo di 1 e 80 (volendo esagerare) che compete e vince in una lega di superatleti grandi il doppio di lui. Facendoti sperare che anche tu, un giorno, possa riuscirci.
 Il nostro racconto si ferma qui. Perché è giusto interromperlo nel momento di massima gloria del nostro. Che continuerà ancora per un po’ a ledere la dignità altrui con il suo crossover (Antonio Daniels sto parlando con te), ma che non raggiungerà mai più le vette toccate in quell’annata magica. Non sempre per demeriti suoi. Inutile e triste, poi, parlare degli anni di Denver, Memphis e Detroit, come pure del ritorno a Philadelphia nel 2009 o dell’ultima parentesi in Turchia, quando testa e fisico non lo reggono già più. Sono immagini che mi hanno fatto già molto male all’epoca. Né mi interessa che si sia bruciato 200 milioni di dollari, tra eccessi, ostentazioni e amicizie sbagliate e che ora abbia a malapena i soldi per comprarsi da mangiare. Il silenzio dello Staples di fronte alla performance di cui sopra è l’ultimo fotogramma che voglio conservare. Stanotte, prima della partita contro i Washington Wizards, la sua maglia verrà ritirata: resterà per sempre appesa sulla sommità del Wells Fargo Center, magari per ispirare la nuova speranza Sixers, quel Michael Carter Williams di cui tanto bene si parla. Il quale, però, deve sempre ricordare quanto segue: ‹‹I’m Philadelphia. When you think Philadelphia basketball, you think Allen Iverson››. Magari con “My Way” di Sinatra in sottofondo. Respect Mr. Allen Iverson!
Il nostro racconto si ferma qui. Perché è giusto interromperlo nel momento di massima gloria del nostro. Che continuerà ancora per un po’ a ledere la dignità altrui con il suo crossover (Antonio Daniels sto parlando con te), ma che non raggiungerà mai più le vette toccate in quell’annata magica. Non sempre per demeriti suoi. Inutile e triste, poi, parlare degli anni di Denver, Memphis e Detroit, come pure del ritorno a Philadelphia nel 2009 o dell’ultima parentesi in Turchia, quando testa e fisico non lo reggono già più. Sono immagini che mi hanno fatto già molto male all’epoca. Né mi interessa che si sia bruciato 200 milioni di dollari, tra eccessi, ostentazioni e amicizie sbagliate e che ora abbia a malapena i soldi per comprarsi da mangiare. Il silenzio dello Staples di fronte alla performance di cui sopra è l’ultimo fotogramma che voglio conservare. Stanotte, prima della partita contro i Washington Wizards, la sua maglia verrà ritirata: resterà per sempre appesa sulla sommità del Wells Fargo Center, magari per ispirare la nuova speranza Sixers, quel Michael Carter Williams di cui tanto bene si parla. Il quale, però, deve sempre ricordare quanto segue: ‹‹I’m Philadelphia. When you think Philadelphia basketball, you think Allen Iverson››. Magari con “My Way” di Sinatra in sottofondo. Respect Mr. Allen Iverson!
Claudio Pellecchia
Nasce a Napoli il 07/09/1987. Già collaboratore/redattore per il "Roma", "Il Mattino" e toniiavarone.it, nonostante la laurea in Giurisprudenza ha deciso comunque di intraprendere l'avventura rischiosa e affascinante del giornalismo. Pubblicista dal 2013, ama lo sport e le storie che vi ruotano attorno. Occuparsi di Nba non è un lavoro, ma un piacere.
Articoli Correlati
-
 Diciannove azzurri per Jumping Verona:...
Diciannove azzurri per Jumping Verona:...ott 25, 2024 0
-
 Jumping Verona: tanti i ‘big’...
Jumping Verona: tanti i ‘big’...ott 24, 2024 0
-
 FESTIVAL CINEMA DI ROMA: il 23 ottobre...
FESTIVAL CINEMA DI ROMA: il 23 ottobre...ott 15, 2024 0
-
 Fieracavalli 2024: Il grande Sport...
Fieracavalli 2024: Il grande Sport...ott 14, 2024 0
Altre Notizie
-
 Carlos Coronel, Noah Eile e Lewis...
Carlos Coronel, Noah Eile e Lewis...ott 08, 2024 0
-
 Crew stun Red Bulls in stoppage time,...
Crew stun Red Bulls in stoppage time,...ott 01, 2022 0
-
 Gonzalo Higuain delivers late heroics...
Gonzalo Higuain delivers late heroics...set 30, 2022 0
-
 Union scorers come through in 2-0 win...
Union scorers come through in 2-0 win...set 03, 2022 0
Seguici su Facebook
PATRIMONIO ITALIANO AWARD
PATRIMONIO ITALIANO TV
-

-

-
 LET’S SING @ RADIO ITALIA: Il Karaoke per Nintendo Wii
LET’S SING @ RADIO ITALIA: Il Karaoke per Nintendo Wiiott 01, 2013 6
-
 Ecco i Microfoni wireless di SingStar per Playstation
Ecco i Microfoni wireless di SingStar per Playstationmag 22, 2009 5
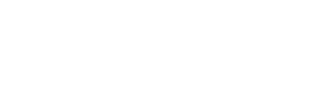



11 years ago
11 years ago
11 years ago
11 years ago