Ultime Notizie
- Diciannove azzurri per Jumping Verona: ai 9 convocati dalla FISE si sono aggiunte 10 “wild card”
- Jumping Verona: tanti i ‘big’ attesi per la tappa di Coppa del Mondo
- FESTIVAL CINEMA DI ROMA: il 23 ottobre al Teatro Olimpico proiezione ufficiale del documentario dedicato al pilota Giacomo Agostini
- Fieracavalli 2024: Il grande Sport Nazionale e Internazionale è di scena al padiglione 8
- Fieracavalli 2024: Il Western Show, il mondo USA, è nel padiglione 12
Storie da All Star Game: la notte in cui Kobe Bryant rovinò la festa di MJ.
feb 07, 2014 Claudio Pellecchia Sport USA 0
 Roma. ‹‹Creatura affascinante il black mamba. Senti qua. In Africa c’è un adagio che dice: nella boscaglia un elefante può ucciderti, un leopardo può ucciderti e un black mamba può ucciderti. Ma solo con il black mamba, e questo è vero in Africa fin dall’alba dei tempi, la morte è sicura››. Personalmente ignoro se e quanto Quentin Tarantino o Daryl Hannah (memorabile interprete della scena da cui è ripresa la citazione poco sopra) siano tifosi di basket, dei Los Angeles Lakers e di Kobe Bryant. Di certo, però, il parallelo tra il 24 in purple and gold e uno degli animali più letali del globo terracqueo, oltre che a sfociare in interessantissime prospettive commerciali e di marketing, è stato quantomai illuminante e illuminato. Proprio come certi animali che, in natura, uccidono per il puro gusto di farlo senza avere la necessità di procurarsi il cibo, allo stesso modo il figlio di Jellybean, nel corso della sua carriera, ha interpretato il ruolo di chi ha voluto sempre vincere, anzi stravincere, anche quando non ce ne sarebbe stato bisogno. Detto che la testa è quella dell’uomo che ha fatto causa alla madre perché non vendesse i suoi cimeli dei tempi del liceo per comprarsi una casa a Las Vegas (giova ricordare che, all’epoca dei fatti, l’ultimo anno di contratto con i Lakers prima del rinnovo chiamava per 31, TRENTUNO, milioni di dollari), siamo di fronte al classico esempio di chi si trova a dover quotidianamente fare i conti con il demone dell’ossessività. Nel caso di Bryant si tratta di ossessività per la vittoria. Sempre, comunque, a qualunque costo. E non può essere altrimenti: senza la fase ossessiva, senza la ripetitività di quell’istinto a migliorarsi per rimanere in alto, non può esserci il campione. E Kobe non potrebbe essere ancora lì dove è ora (recenti infortuni permettendo) se, partita dopo partita, anno dopo anno, non avesse accentuato sempre di più questa sua animalesca voglia di primeggiare. Su chiunque e in qualunque contesto. Alla luce di tutto ciò sarebbe difficile da credere che un uomo simile abbia avuto un idolo, un modello, qualcuno cui ispirarsi. Qualcuno da emulare non solo nell’espressione del proprio sconfinato talento sul parquet, ma anche nel modo di porre tale talento al servizio di quel demone chiamato “voglia di vincere”. Ebbene quest’idolo esiste e ha nome, fattezze e carisma di Michael Jeffrey Jordan, ispiratore di Bryant e responsabile principale della ferocia assassina che quest’ultimo mette sul terreno di gioco, che sia pre-season o gara 7 delle Finals contro Boston. Chi avesse tempo e voglia di andarsi a guardare il curriculum del prodotto di Lower Merion High School (ah già, dimenticavo: costui ha fatto il salto in Nba direttamente dal liceo) vi troverebbe, oltre ai 5 anelli: 2 medaglie d’oro olimpiche, 2 titoli di Mvp delle finali (oltre a quello di Mvp della regular season 2008), 2 trofei di capocannoniere, 4 riconoscimenti come miglior giocatore all’All Star Game, una vittoria allo “Slam Dunk Contest” e una sfilza infinita di record che sarebbe persino noioso mettersi ad elencare. Eppure, se ne parlaste con il diretto interessato, notereste una luce sinistra nei suoi occhi, figlia dell’insoddisfazione tipica di chi sente di avere ancora qualcosa da fare; nel caso di specie, si tratta del sesto trofeo di campione, l’unico che ancora gli manca per mettersi in pari con Jordan. Eguagliare MJ: una blasfemia per qualunque appassionato di sport al di là dell’Atlantico: non certo per chi, a 18 anni, impatta come un meteorite sulla lega più importante del mondo. Eppure, impatto a parte, i primi confronti contro quello che fino ad allora era stata una semplice figura all’interno di uno schermo televisivo, sono tutti uguali: respinto con perdite, come forse è anche giusto che sia. Non basta la sfrontatezza e la giovanile incoscienza per competere alla pari con chi ha completamente stravolto il modo di intendere il gioco. Ma è soltanto questione di tempo: mentre il Pai Mei col 23 si trova a dover fronteggiare Kronos, l’unico avversario che non può battere, il black mamba con l’8 (che diventerà poi 24) prende progressivamente coscienza della macchina da pallacanestro che può diventare. In mezzo passano un secondo ritiro provvisorio per l’uno e un “Three-peat” in combutta con Shaquille O’Neal per l’altro. Inevitabile, scontato, necessario che debbano scontrarsi ancora un’ultima volta. In “Kill Bill” il redde rationem avviene in un anonimo giardino illuminato dalla splendida luna messicana. Nel nostro caso, il contesto è un attimino più pomposo e dalla visibilità più ampia: All Star Game 2003, Phillips Arena di Atlanta (a due passi dalla fabbrica della nota bevanda con le bollicine che alcuni di voi staranno sorseggiando, probabilmente in questo momento). Per Jordan è l’ultima apparizione alla partita delle stelle. Lo sa lui, lo sanno i compagni e avversari, lo sa, di fatto, l’intero pianeta. E conta relativamente che, a quarant’anni, non sia più il migliore (come detto, Kronos si è dimostrato avversario ben più tosto di Malone, Magic e Ewing) e in campo faccia una fatica immane a fare canestro (sebbene qualche quarantello sgorgasse ancora dalle divine falangi): quella del 9 febbraio deve essere la sua partita, l’ideale commiato del più grande tra i più grandi. E, in effetti, tutto il carrozzone di contorno viene acchittato in tal senso: lo sponsor personale con lo “swoosh” manda in onda il memorabile spot “Love of the game”, con tanto di invito ai posteri a “playing every game as if it’s your last”; le interviste del pre gara sono un interminabile fiume di peana per l’uomo da North Carolina; le clip video sulla nascita della leggenda si sprecano, fino a assumere i tratti dell’agiografia superflua; l’interpretazione di “Hero” da parte di Mariah Carey, nel corso dell’intervallo, risulta quasi fuori luogo. Michael si sottopone malvolentieri a tutto questo: dipendesse da lui, ogni cosa si limiterebbe ai 15 metri per 28 della Phillips Arena. Perché tutto lo spettacolo, la magia, l’imprevedibilità di questo sport meraviglioso è rinchiuso lì. Lo script è quello classico di ogni All Star Game: primi tre quarti di partita costeggiata difensivamente, ad uso e consumo del sollazzo dei ventimila paganti. Si fa sul serio a partire dagli ultimi 5 minuti del quarto periodo. Anche Maestro e Allievo, l’un contro l’altro armati, si adeguano (o, almeno, sembrano adeguarsi) consci entrambi che l’unico finale possibile deve (dovrebbe) essere il seguente: ultimi secondi, palla al 23 per l’ultimo tiro che vince la partita per l’Est. Il primo tentativo va a vuoto, con il fade away sputato dal ferro (emblema di una serata da 9/27 al tiro per 20 punti complessivi). Si va all’overtime e, stavolta, tutto sembra andare nella direzione giusta, quella da finale disneyano: venti secondi alla sirena, coach Isiah Thomas (si, QUELL’Isiah Thomas, l’esautorato di Barcellona ’92: inutile ricordare su “richiesta” di chi) disegna lo schema che tutti vogliono. Jason Kidd, uno che in un’altra vita avrebbe potuto fare il regista visti i tempi scenici perfetti di ogni sua giocata, tiene la palla il giusto prima di recapitarla a chi di dovere. Shawn Marion difende, per davvero e anche oltre il concetto di perfezione: ma su QUEL movimento non c’è (e non ci sarà mai) niente da fare. La dolcezza del rumore prodotto dalla retina che si muove è inversamente proporzionale al boato della folla. Michael Jeffrey Jordan!!! (cit.) Finisce qui. O meglio, finirebbe qui se dall’altra parte non ci fosse Bryant Kobe da Philadelphia. Quel tiro dalla bellezza abbacinante non ha suscitato ammirazione o giusta riverenza per l’idolo d’infanzia: quel tiro, semplicemente, non ha fatto altro che risvegliare il demone della vittoria ad ogni costo. Ma mancano appena tre secondi, cosa volete che faccia? Rimessa, partenza a destra, palleggio arresto e tiro completamente fuori equilibrio, contrato da Jermaine O’Neal nella parte del pollo: fallo e tre tiri liberi, con il palazzetto che, per una sorta di crudele contrappasso, ricorda Salt Lake City ’98. Silenzio assordante e tanti saluti alla festa in onore di Michael. Per la cronaca vanno a bersaglio due liberi su tre e l’ulteriore beffa della vittoria dell’Ovest sull’ultimo possesso viene scongiurata (per la precisione rimandata, visto che quelli in maglia rossa vinceranno al secondo supplementare). Ma conta relativamente, perché l’affronto sognato per anni viene mandato a compimento nel modo più beffardo e crudele: nel momento perfetto, visto nell’ottica di un Bryant mai così tarantiniano come in quell’occasione. Concluderà con 22 punti, 7 rimbalzi e 6 recuperi: statische, robetta da imbrattacarte. L’importante è aver offerto il giusto sacrificio al suo demone. Un demone che, a distanza di 11 anni non è ancora sazio. Altrimenti non sarebbe Kobe Bryant.
Roma. ‹‹Creatura affascinante il black mamba. Senti qua. In Africa c’è un adagio che dice: nella boscaglia un elefante può ucciderti, un leopardo può ucciderti e un black mamba può ucciderti. Ma solo con il black mamba, e questo è vero in Africa fin dall’alba dei tempi, la morte è sicura››. Personalmente ignoro se e quanto Quentin Tarantino o Daryl Hannah (memorabile interprete della scena da cui è ripresa la citazione poco sopra) siano tifosi di basket, dei Los Angeles Lakers e di Kobe Bryant. Di certo, però, il parallelo tra il 24 in purple and gold e uno degli animali più letali del globo terracqueo, oltre che a sfociare in interessantissime prospettive commerciali e di marketing, è stato quantomai illuminante e illuminato. Proprio come certi animali che, in natura, uccidono per il puro gusto di farlo senza avere la necessità di procurarsi il cibo, allo stesso modo il figlio di Jellybean, nel corso della sua carriera, ha interpretato il ruolo di chi ha voluto sempre vincere, anzi stravincere, anche quando non ce ne sarebbe stato bisogno. Detto che la testa è quella dell’uomo che ha fatto causa alla madre perché non vendesse i suoi cimeli dei tempi del liceo per comprarsi una casa a Las Vegas (giova ricordare che, all’epoca dei fatti, l’ultimo anno di contratto con i Lakers prima del rinnovo chiamava per 31, TRENTUNO, milioni di dollari), siamo di fronte al classico esempio di chi si trova a dover quotidianamente fare i conti con il demone dell’ossessività. Nel caso di Bryant si tratta di ossessività per la vittoria. Sempre, comunque, a qualunque costo. E non può essere altrimenti: senza la fase ossessiva, senza la ripetitività di quell’istinto a migliorarsi per rimanere in alto, non può esserci il campione. E Kobe non potrebbe essere ancora lì dove è ora (recenti infortuni permettendo) se, partita dopo partita, anno dopo anno, non avesse accentuato sempre di più questa sua animalesca voglia di primeggiare. Su chiunque e in qualunque contesto. Alla luce di tutto ciò sarebbe difficile da credere che un uomo simile abbia avuto un idolo, un modello, qualcuno cui ispirarsi. Qualcuno da emulare non solo nell’espressione del proprio sconfinato talento sul parquet, ma anche nel modo di porre tale talento al servizio di quel demone chiamato “voglia di vincere”. Ebbene quest’idolo esiste e ha nome, fattezze e carisma di Michael Jeffrey Jordan, ispiratore di Bryant e responsabile principale della ferocia assassina che quest’ultimo mette sul terreno di gioco, che sia pre-season o gara 7 delle Finals contro Boston. Chi avesse tempo e voglia di andarsi a guardare il curriculum del prodotto di Lower Merion High School (ah già, dimenticavo: costui ha fatto il salto in Nba direttamente dal liceo) vi troverebbe, oltre ai 5 anelli: 2 medaglie d’oro olimpiche, 2 titoli di Mvp delle finali (oltre a quello di Mvp della regular season 2008), 2 trofei di capocannoniere, 4 riconoscimenti come miglior giocatore all’All Star Game, una vittoria allo “Slam Dunk Contest” e una sfilza infinita di record che sarebbe persino noioso mettersi ad elencare. Eppure, se ne parlaste con il diretto interessato, notereste una luce sinistra nei suoi occhi, figlia dell’insoddisfazione tipica di chi sente di avere ancora qualcosa da fare; nel caso di specie, si tratta del sesto trofeo di campione, l’unico che ancora gli manca per mettersi in pari con Jordan. Eguagliare MJ: una blasfemia per qualunque appassionato di sport al di là dell’Atlantico: non certo per chi, a 18 anni, impatta come un meteorite sulla lega più importante del mondo. Eppure, impatto a parte, i primi confronti contro quello che fino ad allora era stata una semplice figura all’interno di uno schermo televisivo, sono tutti uguali: respinto con perdite, come forse è anche giusto che sia. Non basta la sfrontatezza e la giovanile incoscienza per competere alla pari con chi ha completamente stravolto il modo di intendere il gioco. Ma è soltanto questione di tempo: mentre il Pai Mei col 23 si trova a dover fronteggiare Kronos, l’unico avversario che non può battere, il black mamba con l’8 (che diventerà poi 24) prende progressivamente coscienza della macchina da pallacanestro che può diventare. In mezzo passano un secondo ritiro provvisorio per l’uno e un “Three-peat” in combutta con Shaquille O’Neal per l’altro. Inevitabile, scontato, necessario che debbano scontrarsi ancora un’ultima volta. In “Kill Bill” il redde rationem avviene in un anonimo giardino illuminato dalla splendida luna messicana. Nel nostro caso, il contesto è un attimino più pomposo e dalla visibilità più ampia: All Star Game 2003, Phillips Arena di Atlanta (a due passi dalla fabbrica della nota bevanda con le bollicine che alcuni di voi staranno sorseggiando, probabilmente in questo momento). Per Jordan è l’ultima apparizione alla partita delle stelle. Lo sa lui, lo sanno i compagni e avversari, lo sa, di fatto, l’intero pianeta. E conta relativamente che, a quarant’anni, non sia più il migliore (come detto, Kronos si è dimostrato avversario ben più tosto di Malone, Magic e Ewing) e in campo faccia una fatica immane a fare canestro (sebbene qualche quarantello sgorgasse ancora dalle divine falangi): quella del 9 febbraio deve essere la sua partita, l’ideale commiato del più grande tra i più grandi. E, in effetti, tutto il carrozzone di contorno viene acchittato in tal senso: lo sponsor personale con lo “swoosh” manda in onda il memorabile spot “Love of the game”, con tanto di invito ai posteri a “playing every game as if it’s your last”; le interviste del pre gara sono un interminabile fiume di peana per l’uomo da North Carolina; le clip video sulla nascita della leggenda si sprecano, fino a assumere i tratti dell’agiografia superflua; l’interpretazione di “Hero” da parte di Mariah Carey, nel corso dell’intervallo, risulta quasi fuori luogo. Michael si sottopone malvolentieri a tutto questo: dipendesse da lui, ogni cosa si limiterebbe ai 15 metri per 28 della Phillips Arena. Perché tutto lo spettacolo, la magia, l’imprevedibilità di questo sport meraviglioso è rinchiuso lì. Lo script è quello classico di ogni All Star Game: primi tre quarti di partita costeggiata difensivamente, ad uso e consumo del sollazzo dei ventimila paganti. Si fa sul serio a partire dagli ultimi 5 minuti del quarto periodo. Anche Maestro e Allievo, l’un contro l’altro armati, si adeguano (o, almeno, sembrano adeguarsi) consci entrambi che l’unico finale possibile deve (dovrebbe) essere il seguente: ultimi secondi, palla al 23 per l’ultimo tiro che vince la partita per l’Est. Il primo tentativo va a vuoto, con il fade away sputato dal ferro (emblema di una serata da 9/27 al tiro per 20 punti complessivi). Si va all’overtime e, stavolta, tutto sembra andare nella direzione giusta, quella da finale disneyano: venti secondi alla sirena, coach Isiah Thomas (si, QUELL’Isiah Thomas, l’esautorato di Barcellona ’92: inutile ricordare su “richiesta” di chi) disegna lo schema che tutti vogliono. Jason Kidd, uno che in un’altra vita avrebbe potuto fare il regista visti i tempi scenici perfetti di ogni sua giocata, tiene la palla il giusto prima di recapitarla a chi di dovere. Shawn Marion difende, per davvero e anche oltre il concetto di perfezione: ma su QUEL movimento non c’è (e non ci sarà mai) niente da fare. La dolcezza del rumore prodotto dalla retina che si muove è inversamente proporzionale al boato della folla. Michael Jeffrey Jordan!!! (cit.) Finisce qui. O meglio, finirebbe qui se dall’altra parte non ci fosse Bryant Kobe da Philadelphia. Quel tiro dalla bellezza abbacinante non ha suscitato ammirazione o giusta riverenza per l’idolo d’infanzia: quel tiro, semplicemente, non ha fatto altro che risvegliare il demone della vittoria ad ogni costo. Ma mancano appena tre secondi, cosa volete che faccia? Rimessa, partenza a destra, palleggio arresto e tiro completamente fuori equilibrio, contrato da Jermaine O’Neal nella parte del pollo: fallo e tre tiri liberi, con il palazzetto che, per una sorta di crudele contrappasso, ricorda Salt Lake City ’98. Silenzio assordante e tanti saluti alla festa in onore di Michael. Per la cronaca vanno a bersaglio due liberi su tre e l’ulteriore beffa della vittoria dell’Ovest sull’ultimo possesso viene scongiurata (per la precisione rimandata, visto che quelli in maglia rossa vinceranno al secondo supplementare). Ma conta relativamente, perché l’affronto sognato per anni viene mandato a compimento nel modo più beffardo e crudele: nel momento perfetto, visto nell’ottica di un Bryant mai così tarantiniano come in quell’occasione. Concluderà con 22 punti, 7 rimbalzi e 6 recuperi: statische, robetta da imbrattacarte. L’importante è aver offerto il giusto sacrificio al suo demone. Un demone che, a distanza di 11 anni non è ancora sazio. Altrimenti non sarebbe Kobe Bryant.
Claudio Pellecchia
Nasce a Napoli il 07/09/1987. Già collaboratore/redattore per il "Roma", "Il Mattino" e toniiavarone.it, nonostante la laurea in Giurisprudenza ha deciso comunque di intraprendere l'avventura rischiosa e affascinante del giornalismo. Pubblicista dal 2013, ama lo sport e le storie che vi ruotano attorno. Occuparsi di Nba non è un lavoro, ma un piacere.
Articoli Correlati
-
 Diciannove azzurri per Jumping Verona:...
Diciannove azzurri per Jumping Verona:...ott 25, 2024 0
-
 Jumping Verona: tanti i ‘big’...
Jumping Verona: tanti i ‘big’...ott 24, 2024 0
-
 FESTIVAL CINEMA DI ROMA: il 23 ottobre...
FESTIVAL CINEMA DI ROMA: il 23 ottobre...ott 15, 2024 0
-
 Fieracavalli 2024: Il grande Sport...
Fieracavalli 2024: Il grande Sport...ott 14, 2024 0
Altre Notizie
-
 Carlos Coronel, Noah Eile e Lewis...
Carlos Coronel, Noah Eile e Lewis...ott 08, 2024 0
-
 Crew stun Red Bulls in stoppage time,...
Crew stun Red Bulls in stoppage time,...ott 01, 2022 0
-
 Gonzalo Higuain delivers late heroics...
Gonzalo Higuain delivers late heroics...set 30, 2022 0
-
 Union scorers come through in 2-0 win...
Union scorers come through in 2-0 win...set 03, 2022 0
Seguici su Facebook
PATRIMONIO ITALIANO AWARD
PATRIMONIO ITALIANO TV
-

-

-
 LET’S SING @ RADIO ITALIA: Il Karaoke per Nintendo Wii
LET’S SING @ RADIO ITALIA: Il Karaoke per Nintendo Wiiott 01, 2013 6
-
 Ecco i Microfoni wireless di SingStar per Playstation
Ecco i Microfoni wireless di SingStar per Playstationmag 22, 2009 5
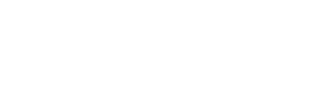



11 years ago
11 years ago
11 years ago
11 years ago